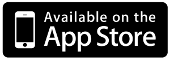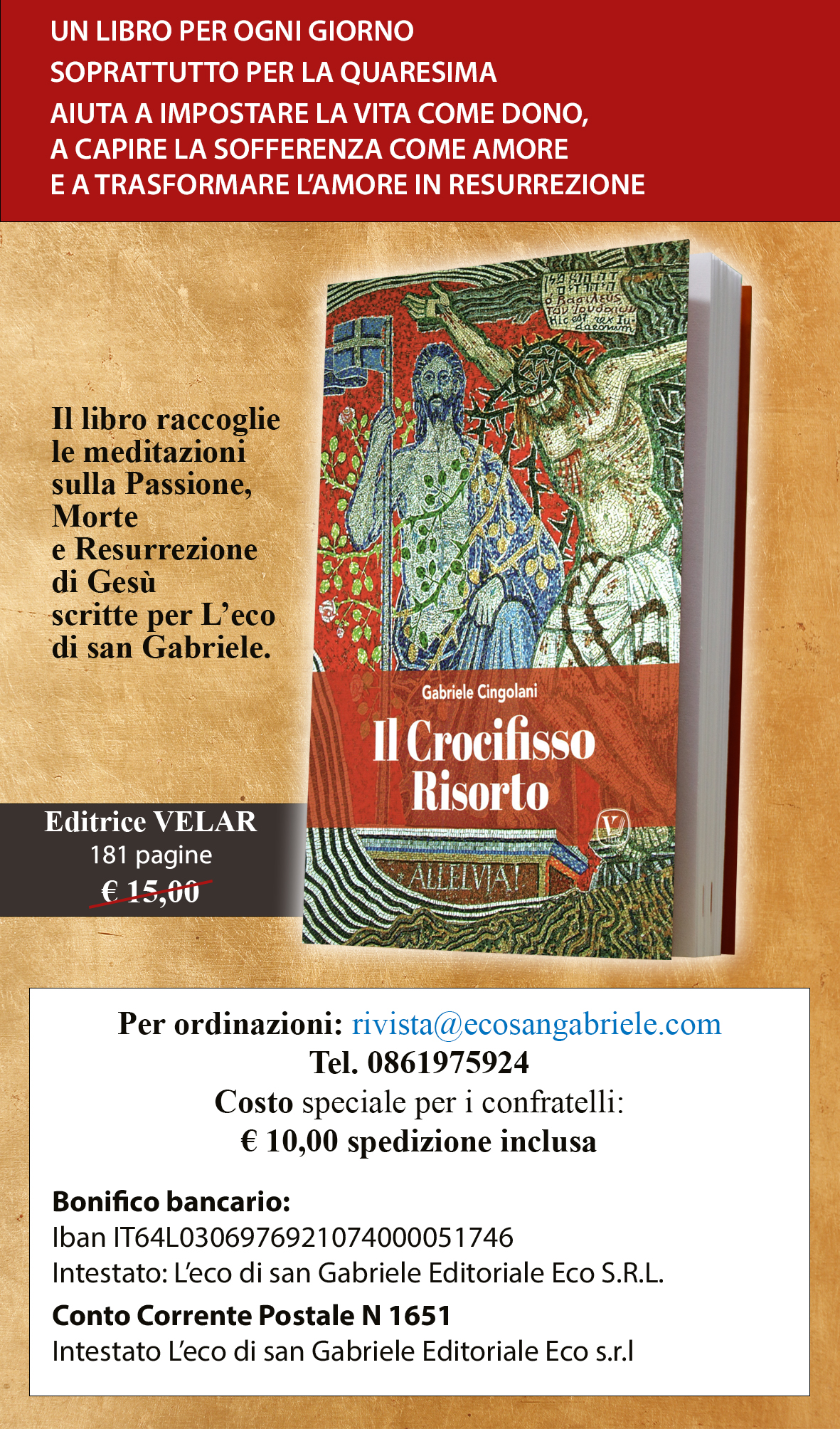“LA VITA MI APPASSIONA MOLTO PIù DELLA MORTE…”
Da una parte il Vangelo, dall’altra la Costituzione. In mezzo, lui, don Luigi Ciotti, un uomo e un prete che ha scelto di essere dalla parte degli esclusi, dei dimenticati, degli ultimi. Uno che ha sempre occupato l’ultima sedia, che all’io preferisce il noi, che ha sempre battuto i territori delle periferie nutrendosi del desiderio di dare risposte agli stimoli di una realtà che, al netto di paillettes e luccichii, è infarcita di tanta disperazione. Dalle povertà materiali a quelle culturali, dalla droga all’immigrazione, dall’alcolismo alla prostituzione, dalle guerre alle vittime della mafia, e così via…
Come vedremo nell’intervista, rifiuta ogni tipo di etichetta, per lui conta solo il fare… Ovviamente cercando di coinvolgere più persone possibili e tenendo saldamente i piedi per terra… Proprio come ripeteva spesso il rimpianto arcivescovo brasiliano Hélder Pessoa Camara, una vita spesa a coniugare vangelo e giustizia: Il massimo che si può fare da soli è sempre meno del minimo che si può fare insieme. Questo perché la solidarietà e la giustizia rappresentano bisogni dai quali nessuno può prescindere. Ed ecco allora che nel 1956 don Ciotti fonda il Gruppo Abele, associazione che promuove l’inclusione e la giustizia sociale. Un impegno che nel tempo, poi, si è allargato alla denuncia e al contrasto del potere mafioso con la nascita di Libera (1994). Parliamo di una preziosa e grande rete (1.600 organizzazioni nazionali e internazionali fra cui diverse sigle del mondo dell’associazionismo, della scuola, della cooperazione e del sindacato) il cui impegno è rivolto contro le mafie, la corruzione e i fenomeni criminali. Natural-mente inseguendo, parallelamente, la giustizia sociale, la ricerca della verità e la tutela dei diritti.
Una lotta co-stante e senza frontiere che da diversi anni lo costringe a vivere sotto scorta. In un’interccettazione, infatti, la mafia aveva decretato la sua eliminazione. Il suo non è stato mai un cristianesimo borghese, comodo, si è sempre messo in gioco scegliendo il rischio della testimonianza. Da sua madre, che gli ha insegnato il segno della croce e le preghiere recitate in camera insieme a lei e alle sorelle (il papà era spesso assente per lavoro), ha ereditato l’essenza del messaggio cristiano. Niente baci ai santini e inchini alle icone, ma un cuore che lavora per il bene del prossimo. Quel prossimo identificato da Gesù nel buon samaritano e che evidenzia come ogni essere umano, nessuno escluso, abbia bisogno di chi si pieghi su lui.
Don Luigi l’ho conosciuto anni fa in occasione di un convengo sulla mafia organizzato a Roma, nella sede Rai di Viale Mazzini. È stato “un amore a prima vista”, tanta concretezza e sempre “l’altro” al centro del suo interesse. Ora ci siamo risentiti in occasione della sua ultima e interessantissima pubblicazione, L’amore non basta (Scrittori Giunti, pp.319, euro 18,00). Una sorta di autobiografia collettiva che racconta un’esistenza fuori dal comune.
Don Ciotti, il titolo del suo ultimo libro mi ha sorpreso… Credevo che l’amore fosse l’unica cura efficace per i mali del nostro pianeta…
Il titolo è evidentemente provocatorio. Come altre stupende parole, anche il verbo amare viene oggi abusato e dunque svilito, svuotato di significato. Tutti si riempiono la bocca con l’amore ma in pochi lo praticano nel suo senso più pieno, che per un cristiano è poi quello evangelico. L’amore invocato da sant’Agostino nella famosa esortazione: Ama e fa ciò che vuoi, come l’amore celebrato da san Paolo nella lettera ai Corinzi, è lo stesso amore che Gesù ci chiede di riservare al Padre e al prossimo. Ed è un amore impegnativo, che chiama al sacrificio di sé, anzi a una forma di dimenticanza del sé. Non certo l’amore egoistico che molti intendono al giorno d’oggi: amore dell’io per l’io, che fa dell’altro uno strumento di gratificazione personale. L’amore vero è quello che vede nell’altro non un mezzo ma sempre un fine, che riconosce l’altro come parte di sé, si arricchisce della sua presenza e al contempo sente propria qualsiasi ingiustizia che l’altro subisce, qualsiasi diritto negato. Questo amore è preludio all’impegno per garantire il benessere a ogni forma di vita sulla terra, umana e non solo.
Come mai ha deciso di raccontarsi? Non vorrà mica mollare… In giro c’è ancora tanto bisogno del suo impegno nella difesa dei più deboli e della giustizia sociale…
L’impegno non è affatto “mio”, e questo dal libro spero emerga in modo chiaro. È ed è sempre stato un impegno collettivo, così come collettivo è il racconto che ho voluto darne. Non a caso, molte pagine sono scritte al plurale, e l’intero testo è in fondo concepito come un lungo ringraziamento alle tante persone che hanno arricchito la mia vita col loro esempio, le loro fatiche e le loro speranze. Quanto al “mollare”, non sarò io a decidere. Finché le forze me lo consentiranno continuerò nell’impegno, semplicemente perché la mia vita è quell’impegno, si identifica completamente in esso. È la mia vocazione, che ritengo un privilegio aver scoperto ed essere riuscito ad assecondare, anche appunto grazie ai tanti incontri che mi hanno aiutato, a non perdere mai di vista la strada.
Nel libro racconta quando a sei anni scagliò il calamaio contro la maestra che, nel rimproverarla ingiustamente, la chiamò montanaro… Le ingiustizie non le ha mai sopportate…
È un aneddoto che avevo già raccontato tante volte in passato, tanto da dubitare se fosse il caso di riprenderlo nel libro. Eppure, a quasi 70 anni di distanza, quell’episodio infantile continuava a sembrarmi centrale… La tendenza di molti ad etichettare con superficialità, a discriminare, ad approfittare delle debolezze dell’altro invece di accoglierle e accompagnarle, è qualcosa che mi ha sempre turbato proprio perché l’ho subito sulla mia pelle da bambino, quando ero più fragile ed esposto. Istintivamente, fin da allora avevo colto quanto quel tipo di atteggiamento potesse influire sull’esistenza di chi ne era vittima, trasformando il disagio e la frustrazione in scelte sbagliate, come certamente sbagliato fu il mio gesto di scagliare il calamaio contro la maestra.
Come la presero i suoi genitori?
Non minimizzarono né giustificarono, anzi furono molto duri nel condannare il mio comportamento. Però io colsi nei loro sguardi anche un fondo di comprensione. Perché la discriminazione verso chi veniva da fuori, come noi emigrati da poco dal Veneto a Torino, era diffusa in quegli anni non meno di quanto lo sia adesso verso gli immigrati dalle zone più povere del mondo. Mamma e papà capirono, io credo, lo smarrimento che mi aveva colto di fronte alle parole della maestra, che oltretutto avevano trasformato in un rimprovero, se non addirittura in un insulto, ciò che per me, per noi, era invece un pezzetto importante dell’identità: il legame con le nostre amate montagne.
Nel suo curriculum di adolescente “ribelle” c’è anche un vasto incendio appiccato per incuria mentre cercava di abbrustolire dei semi di zucca…
Quella però non fu ribellione, ma pura incoscienza e stupidità. Fu una vera lezione per me vedere come i contadini di quel borgo della Maremma, dove ci eravamo temporaneamente trasferiti per seguire mio padre impegnato in un cantiere, reagirono al dramma. Tutti si attivarono immediatamente per sostenere le famiglie danneggiate dall’incendio nel fienile, ciascuno donando uno o più covoni di fieno per ricostituire la scorta andata perduta. Tutti pensarono al benessere della comunità prima che al proprio tornaconto, consapevoli che l’impoverimento degli uni avrebbe potuto toccare anche gli altri, e che una solidarietà immediata era l’unico modo per preservare il legame sociale e la tenuta di quella magra economia rurale.
Però c’è anche il gesto amorevole di regalare a un senzatetto il cappotto di suo padre. Ovviamente senza che lui ne sapesse niente…
Si trattava di un vecchio cappotto… ma per noi che avevamo conosciuto la povertà vera, qualsiasi indumento andava sfruttato fino in fondo. Per lo stesso motivo, però, mio padre non si arrabbiò affatto: capì che, se avevo osato quel piccolo “furto” domestico, era perché il destinatario del cappotto ne aveva più bisogno di lui.
Che ricordo ha dei suoi genitori? Quanto hanno influito nella sua scelta di abbracciare il sacerdozio?
Erano due persone semplici, ma profonde, come le racconto nel libro. La mamma più estroversa, comunicativa, curiosa. Il papà più pragmatico e di scarse parole. Uniti fra loro da un solido legame d’affetto. Sono stati per noi figli un esempio di coerenza fra parole e azioni: ciò che ci insegnavano lo vivevano in prima persona: la responsabilità verso il prossimo, l’accuratezza nel lavoro, la dignità dell’essenziale. In questo senso sono stati educatori veri. E anche la testimonianza di fede che ci hanno trasmesso si giocava su questa continua corrispondenza fra la parola e le scelte concrete. Come in molte famiglie venete, anche nella nostra si respirava un cattolicesimo sociale attento a realizzare, per quanto possibile, con umiltà di mezzi e atteggiamento, il Regno dei Cieli già sulla Terra. Tuttavia devo dire che la mia scelta di farmi sacerdote colse tutti di sorpresa… Sembrò forse da principio un’idea avventata, e solo col tempo i miei genitori e le mie sorelle capirono che facevo sul serio.
Come nacque quella scelta?
Sono entrato in seminario già grande, per l’epoca. Avevo 18 anni quando mi iscrissi a un corso per vocazioni adulte istituito presso il Seminario Maggiore di Rivoli. Ero molto impegnato in parrocchia, e insieme ad alcuni amici avevo iniziato a frequentare certe strade, piazze e caseggiati di periferia, cercando di dare una mano alle persone senza tetto e ai ragazzi cosiddetti “sbandati”, in gran parte immigrati di recente dalle zone più povere d’Italia, disorientati, diffidenti, senza lavoro né studi. Era un tentativo di dare “corpo” ai precetti cristiani di solidarietà che ascoltavo in chiesa e all’Azione Cattolica. Decisi di affrontare il Seminario come un banco di prova: volevo capire se le mie motivazioni erano sufficientemente forti, e la mia fede sufficientemente salda, per fare di quell’impegno accanto agli ultimi un percorso di vita. Dio aveva fissato per me un appuntamento e io ebbi la fortuna di arrivarci puntuale.
Tra le tante persone incontrate nel corso della sua preziosa opera c’è anche don Tonino Bello. Qual è il ricordo più vivo della vostra amicizia?
Una serata di pioggia torrenziale, dalle parti di Molfetta. Don Tonino mi stava accompagnando a visitare una comunità terapeutica aperta, per suo impulso, in una struttura della diocesi. Notammo sul ciglio della strada alcune sagome scure: erano braccianti stranieri, di ritorno da una giornata di lavoro massacrante al soldo dei caporali. Don Tonino volle a tutti i costi arrivare fino alla masseria diroccata dove dormivano. Più tardi mi riaccompagnò alla stazione, e venni poi a sapere che era ritornato da quei ragazzi, portando cibo e coperte e fermandosi a passare la notte in quel loro rifugio di fortuna, per ascoltare le loro storie, trasmettere un messaggio di condivisione e di speranza.
Come e perché nasce il Gruppo Abele?
Il come l’ho in parte già raccontato: dalle attività di un gruppo di ragazzi della parrocchia, decisi a offrire amicizia alle persone emarginate: i “barboni” che dormivano sotto i portici o alla stazione e molti adolescenti delle periferie, lasciati senza prospettive e riferimenti educativi solidi. Il perché divenne chiaro col tempo. All’inizio era soprattutto una testimonianza della nostra fede cristiana, un modo per vivere il Vangelo nella quotidianità. In seguito maturammo un approccio più politico, nel senso alto del termine. Non si trattò più soltanto di dare una mano ai singoli, di intercettare i loro bisogni immediati, ma di porre le basi affinché quel tipo di disagio e di emarginazione fosse sconfitto a livello sociale, attraverso una maggiore consapevolezza collettiva e una maggiore corresponsabilità. Ecco allora che ai progetti di accoglienza e sostegno si aggiunsero la proposta culturale, le manifestazioni pubbliche, la mediazione con le istituzioni locali affinché si attivassero su determinate situazioni, a partire da quella del carcere minorile per continuare con la droga, la prostituzione eccetera.
Delle tante battaglie “scomode” portate avanti quale è riuscita a emozionarla di più?
Non è questione di emozionarsi, come dico sempre, non basta commuoversi, ma bisogna invece muoversi, darsi concretamente da fare. Quando agisci, soprattutto in situazioni di emergenza e di diritti gravemente negati, ti resta poco tempo per i “sentimentalismi”. Ed è un bene, perché altrimenti si rischierebbe di lasciarsi travolgere dall’angoscia e dalla frustrazione. Penso ad esempio al primo periodo di diffusione dell’Aids, quando i malati erano rifiutati dalla società e spesso dalle loro stesse famiglie, considerati colpevoli del male che li aveva colpiti, e si spegnevano in pochi mesi, fra sofferenze fisiche e psicologiche estreme. Nelle nostre comunità celebravamo più di un funerale la settimana. Quasi tutti giovani… E cosa dire delle lacrime di tante mamme, tanti papà, tanti figli a cui la criminalità mafiosa ha strappato gli affetti più cari? Che ti vengono incontro, ti chiedono una parola di conforto, di senso… È chiaro che anche lì uno si sente soverchiato. Ma a tutti va offerta una possibilità di uscita dal dolore.
Ha messo mai in discussione la sua fede? Si è mai chiesto: “Dio perché? Dove sei?”.
Capita a tutti. Ma è proprio in quei momenti che Dio si fa sentire, vedere, toccare. Spesso nel corpo di qualcuno in difficoltà, nella sua richiesta di aiuto. Pensiamo ai volti emaciati, terrorizzati, dei migranti soccorsi in alto mare, dopo aver visto magari morire amici e famigliari lungo una di quelle traversate disumane. Uno si chiede: “Dio dove sei?” e lui ti risponde: “Sono qui, come puoi non vedermi? Io sono fra loro. E tu, invece, dove sei? Perché non vieni a salvare questi tuoi fratelli?”.
Se nomino la parola mafia qual è la prima cosa che le viene in mente?
L’egoismo. La prepotenza. La sete di profitto. La dittatura dell’“io”. La mafia non è un mondo a parte, ma una parte del nostro mondo. È il trionfo di una serie di atteggiamenti che sono propri di ciascun essere umano, e che vanno contrastati prima di tutto dentro noi stessi.
Come andrebbero onorati i tanti caduti per la difesa degli ideali di giustizia e legalità? L’associazione Libera è nata per questo?
Libera è nata per ricordarli nell’unico modo che riteniamo corretto ed efficace: rinnovare il loro impegno, farlo nostro, alimentarlo attraverso progetti educativi, di vita e di lavoro. Attraverso quei diritti sociali – casa, salute, impiego – che, laddove negati, le mafie offrono nella perniciosa forma del “favore”. Attraverso normative sempre più valide nel colpire gli interessi economici mafiosi e tutto quel sistema di connivenze, inefficienze e omertà che consentono loro di prosperare. Attraverso attività che accrescano la consapevolezza dei cittadini: strumenti di informazione intelligenti, attività didattiche mirate, proposte culturali non soltanto di denuncia, ma capaci anche di valorizzare il positivo, i semi di speranza che ogni giorno vengono gettati.
Ritiene che i segnali di riscatto e di ribellione civile registrati in questi anni in Sicilia e nel resto del paese siano sufficienti per contrastare il sistema mafioso?
Ogni piccolo segnale è prezioso. Ogni assunzione di responsabilità da parte dei cittadini e delle istituzioni. Ogni bene confiscato ai boss e riconvertito a uso sociale. Ogni manifestazione di solidarietà a chi è in pericolo. Ogni opportunità creata per i giovani e per i più emarginati. Oltre ovviamente ai grandi sforzi investigativi e giudiziari. Ma tutto questo ancora non basta, e non basta perché le mafie sono capaci di reagire e di trasformarsi, facendo leva però sempre sugli stessi impulsi: l’avidità, l’egoismo e la sete di potere che purtroppo dominano anche fuori dal circuito criminale, in quello che dovrebbe essere il sistema politico ed economico “legale”. Per questo occorre continuare a impegnarsi, anche e soprattutto nel senso di un cambiamento collettivo di mentalità e stili di vita. Perché al giorno d’oggi assecondare un certo tipo di consumismo sfrenato, di clientelismo mascherato da semplice disinvoltura di rapporti, rischia di renderci inconsapevoli alleati delle mafie, complici dei loro interessi.
La Chiesa quale ruolo dovrebbe occupare in questo cammino di “liberazione”?
Quello indicato con forza da figure come padre Puglisi o don Peppe Diana, che per la loro denuncia intransigente dei crimini mafiosi, e per la loro capacità di avviare i giovani delle loro parrocchie su strade radicalmente alternative, hanno pagato con la vita. Si tratta, e questo l’hanno detto senza sconti papa Giovanni Paolo II, papa Benedetto XVI e papa Francesco, di proclamare e praticare l’incompatibilità delle mafie con il Vangelo, di sottrarsi a qualsiasi tentazione di “minimizzare” l’influenza delle mafie anche in ambito cattolico e cristiano, di rifiutare qualsiasi tipo di contiguità, anche quelle che passano attraverso regalie o false forme di devozione.
Quanto è difficile abitare i territori, essere presenti con proposte e anche con denunce, rinunciando a compromessi o ai richiami del nostro “quieto vivere”?
La domanda non è quanto sia difficile, ma quando sia necessario. E quanto ciascuno di noi è in grado di fare, in base anche ai mezzi materiali e culturali di partenza. Il confine fra il bene e il male, fra ciò che è giusto e ciò che è sbagliato, perché calpesta i diritti degli altri, è sempre chiaro. Ma certamente c’è chi nasce in situazioni di svantaggio tali, che fa più fatica a tenere la barra dritta. Ecco perché è importante investire prima di tutto su queste persone, metterle in condizione di scegliere liberamente e responsabilmente della propria vita. È quello che come Libera, ad esempio, cerchiamo di realizzare con progetti a favore delle donne e dei ragazzi che scelgono di allontanarsi dalle famiglie mafiose di origine, o dei minori che affrontano una condanna penale.
Ha qualche ricordo particolare di Falcone e Borsellino?
Incrociai brevemente Falcone, pochi mesi prima della sua morte, a un convegno organizzato dalla Polizia di Stato sul tema del narcotraffico e delle dipendenze. Ma soprattutto ricordo che ero in Sicilia, per motivi diversi, sia il giorno dell’attentato di Capaci che quello della strage di via D’Amelio. A volte la vita ti lancia dei segnali… E in quella tragica estate io sentii il pungolo a mettermi maggiormente in gioco anche in quella terra, su qui temi.
Cosa dire ai tanti famigliari delle vittime?
Non dire ma fare, fare insieme a loro, passo dopo passo, quel cammino difficilissimo che trasforma il dolore più profondo in speranza di cambiamento. Sono tanti i famigliari che mettono tutto il loro tempo libero al servizio della testimonianza: girano l’Italia intera raccontando le storie dei loro cari, il loro impegno, i loro progetti rimasti incompiuti. Vanno nelle scuole e nelle carceri. Nel donare tutte le loro energie, trovano una nuova forza, una nuova fiducia nel futuro.
Pensa mai alla morte? Le fa paura?
Ci penso talvolta, come tutti, ma non è un pensiero ossessivo. Mi fa paura, come a tutti, perché tutti temiamo quel che non conosciamo. Sono un povero essere umano, come tutti, di fronte alla morte come di fronte alla vita. Ma la vita mi appassiona enormemente di più.
Legge e perdono come convivono nella coscienza di un prete di “strada”?
Come spiego nel libro, non amo le etichette: “prete antimafia”, “antidroga”, “di strada”. Un prete è un prete e basta, e le forme in cui svolge il suo ministero sono determinate dalle inclinazioni personali e dai contesti nei quali la vita lo porta. Io sono partito dalla strada, e padre Pellegrino, il vescovo e maestro che mi ordinò sacerdote, volle affidarmi proprio “la strada” come parrocchia. È chiaro che la strada è luogo di errori, di piccoli e grandi crimini, e praticare l’accoglienza significa, anche, praticare il perdono. Ma quanto maggiore è il debito che abbiamo noi verso la strada e chi la abita? Penso alle povertà materiali ed esistenziali, all’assenza di opportunità e di ascolto… Siamo noi che dovremmo chiedere mille volte perdono, e impegnarci per porre fine a un colossale crimine di omissione. Qualsiasi legge dovrebbe essere al servizio della giustizia: laddove la giustizia è negata, o la legge è sbagliata o l’impegno per attuarla è insufficiente.
In che modo la Chiesa può contribuire a coniugare giustizia e verità?
Non c’è giustizia senza verità, questo mi pare ovvio e condivisibile anche dai non credenti. In un’ottica cristiana, conciliare verità e giustizia credo significhi semplicemente vivere appieno il messaggio evangelico. Cioè tradurre la verità più alta, quella della Parola divina, in gesti umili eppure capaci di portare conforto all’altro, a partire dagli ultimi, dagli esclusi.
Ritiene giusto che la Chiesa si occupi di politica?
Certo, se intendiamo la parola nel suo senso più nobile. La politica come servizio per il bene comune, che Paolo VI definiva “la più alta ed esigente forma di carità”, la politica come “sortire insieme dai problemi”, nella definizione di don Milani, è qualcosa che chiama in causa ciascuno di noi, cattolici inclusi. Il Vangelo del resto è un testo fortemente politico, laddove parla di garantire i diritti dei deboli e ripartire le risorse con equità. Mentre io trovo che la Costituzione italiana sia un testo dal valore anche spirituale, nel suo disegno di una società fondata sulla responsabilità reciproca e sull’obbedienza a principi inderogabili. Vangelo e Costituzione dovrebbero essere i due pilastri di chiunque voglia vivere, come diceva don Bosco, da bravo cristiano e onesto cittadino.
Che idea si è fatta del Corona-virus? Ci renderà veramente migliori?
Come ha detto, con la consueta lucidità e potenza, papa Francesco: “Ci credevamo sani in un mondo malato”. Ora la malattia si è manifestata su una scala prima inimmaginabile, ma non sarà la malattia in sé a renderci migliori. Possiamo però sperare che le difficoltà vissute negli ultimi mesi abbiano contribuito a renderci tutti più consapevoli. In primis della tracotanza che avevamo nello sfruttare e calpestare la natura. In secondo luogo delle disuguaglianze estreme, che hanno reso certe zone del mondo e certe fasce della popolazione assai più vulnerabili al virus. Infine, e in positivo, delle potenzialità che abbiamo quando siamo costretti a uscire dagli “automatismi” del nostro vivere quotidiano, da certe routine disumanizzanti. Insieme alla sofferenza, abbiamo visto fiorire forme di solidarietà e di corresponsabilità che credevamo perdute. La consapevolezza è il primo passo verso l’impegno a migliorare. La speranza è che questa consapevolezza abbia messo radici sufficientemente profonde.
Qual è stato l’errore più grande di don Luigi Ciotti?
Il più grande lo devo di sicuro ancora commettere… Mi porto nel cuore alcune storie di persone che ho provato a riaccompagnare alla vita e alla speranza, senza riuscirci. Non so se a causa di errori, di incomprensioni, di fatalità. Ma certo me le porto nel cuore come un’ombra.
Nel corso del suo ministero è stato mai “vicino” alla nomina di vescovo?
Non scherziamo…
Tra cent’anni come vorrebbe che la ricordassero?
Vorrei che “ci” ricordassero. Vorrei che il mio nome non contasse più nulla, ma che restasse memoria di tanti percorsi costruiti per saldare la Terra con il Cielo, mai da solo ma con il contributo di tante persone. Persone credenti o non credenti e però, come disse il giovane magistrato vittima di mafia Rosario Livatino, “credibili” nel loro impegno per la giustizia.