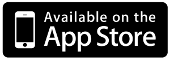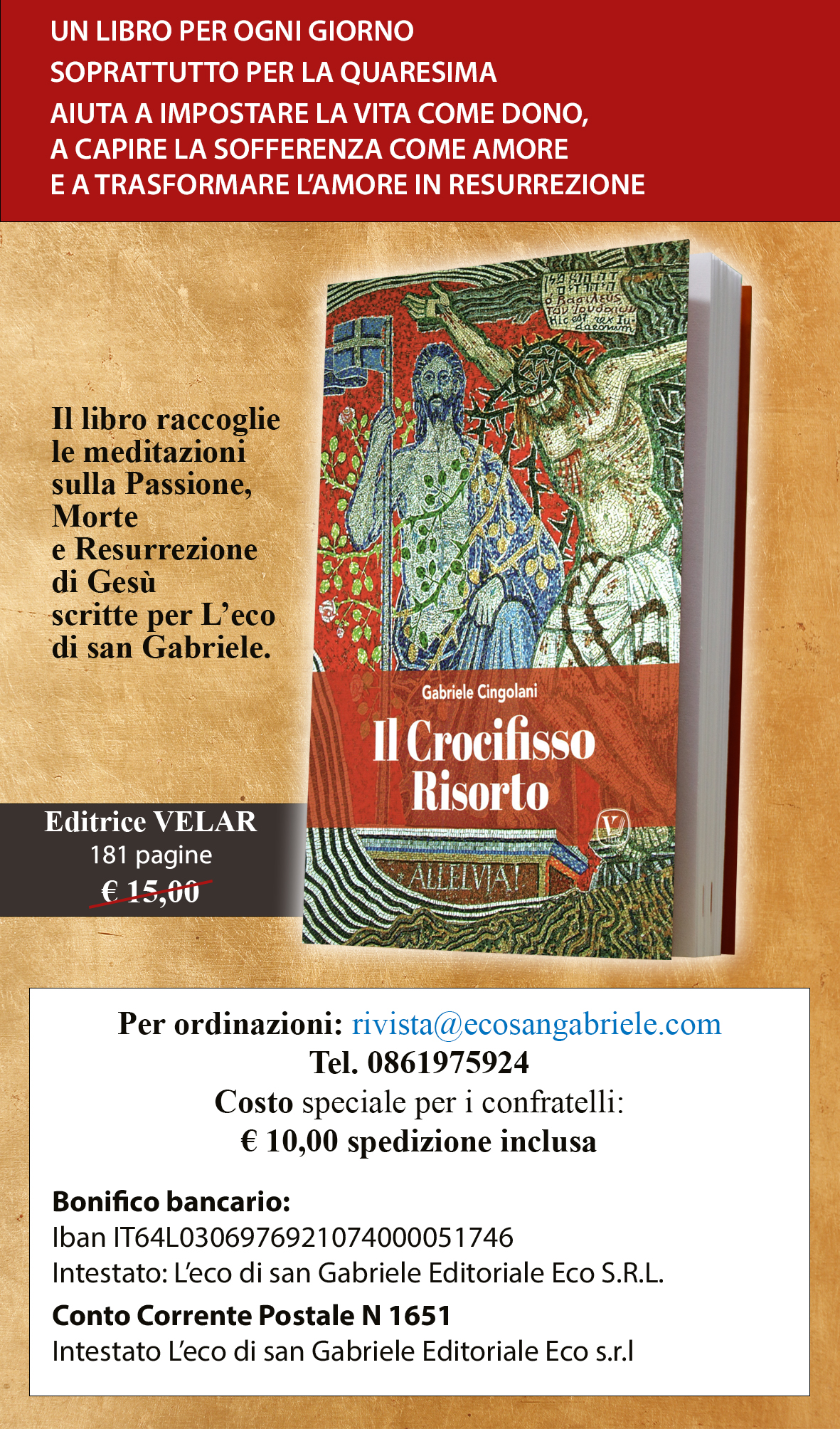A CENTO ANNI DAL GENOCIDIO DEGLI ARMENI
La vigilia del centenario del genocidio armeno, 1915, non rende ancora giustizia alle stragi allora ordinate dalle autorità ottomane contro la minoranza cristiana: si contarono fra un milione e un milione e mezzo di assassinati o morti per fatiche o denutrizione, ma per il governo di Ankara restano, come si dice, un dettaglio della storia. Gli armeni esigono scuse ufficiali e risarcimenti senza aver ottenuto ancora né gli uni né le altre. Con un sapore di beffa perché il premier turco Recep Tayyp Erdogan, con un gesto fatto apparire come una concessione, si è recentemente limitato a indirizzare “condoglianze” ai nipoti delle vittime di un secolo fa, ammettendo le “conseguenze inumane” del massacro.
Si preparano, l’anno prossimo, iniziative e manifestazioni che non piaceranno alla Turchia, con un’offensiva armena verso l’opinione pubblica e i governi occidentali, affinché si induca Ankara ad accettare, con la trattativa, responsabilità storiche. Ma essa non sembra disposta a farlo, a parte il gesto esteriore che agli interessati pare una risposta ulteriormente negativa, quasi per parare in anticipo la valanga di critiche per il silenzio secolare; e anche per un calcolo elettorale di Erdogan, candidato alle presidenziali di agosto.
Eppure, probabilmente, la società turca è pronta a instaurare dialogo. Ce la spingono l’Europa e gli Usa: la prima rallentando il negoziato per l’ingresso di Ankara nella Ue; i secondi, con Barak Obama che incoraggia l’importante alleato (sentinella del Mediterraneo, secondo esercito della Nato) ad andare avanti nell’ammettere il “gran male” che in armeno significa “genocidio”: questa parola specifica il presidente non l’ha pronunciata ma l’ha detta due anni fa, ufficialmente, il congresso americano. La nazione curda, che partecipò al grande carnaio, ha già riconosciuto le proprie colpe, quella turca no.
Circola, nel paese e fuori, una letteratura che rende conto di quei fatti, antichi ma sempre attuali, si moltiplicano le memorie a lungo rimaste nei cassetti dei sopravvissuti, i ricordi raccolti dai discendenti. Un gruppo di giornalisti e scrittori (fra il loro il premio Nobel per la letteratura Pamuck), nonostante che il codice penale punisca chiunque alluda all’avvenimento, esorta il potere ad avere coraggio e diffonde un appello per la ricerca della verità.
Il genocidio degli armeni passò come un episodio minore della grande guerra: con l’accusa di connivenza con il nemico – la Russia – a un popolo a essa legato da radici cristiane e secolari rapporti economico-culturali. Per ottomanizzare l’impero si mise a punto una strategia che iniziò nelle città con l’assassinio degli intellettuali e del clero, dei membri della borghesia produttiva e dei commerci, senza risparmiare le loro famiglie, per estendersi poi in periferia e colpire specialmente contadini e abitanti dell’Anatolia orientale. Non a caso, venti anni più tardi, seguirà quello schema Adolf Hitler, dicendo che se avesse sterminato gli ebrei il mondo non avrebbe fatto una piega, come era successo con gli armeni.
Ma esistono documenti che restituiscono con i dettagli più crudi lo svolgersi dei fatti. Lo dice il Rapporto sulla situazione del popolo armeno in Turchia di Johannese Lepsius, un orientalista tedesco che lo redasse nel 1916 ma non poté vederlo apparire perché avrebbe compromesso le relazioni con un paese alleato in guerra. E un’altra relazione, locale ma molto dettagliata, la si deve a un diplomatico italiano, Giacomo Gorrini, che racconta dello sterminio degli abitanti di Trebisonda nel 1915.
Di tutto quel dramma bisogna continuare a parlare. Perché “il genocidio – ha scritto Primo Levi – uccide due volte: la seconda con il silenzio”.