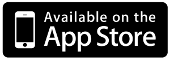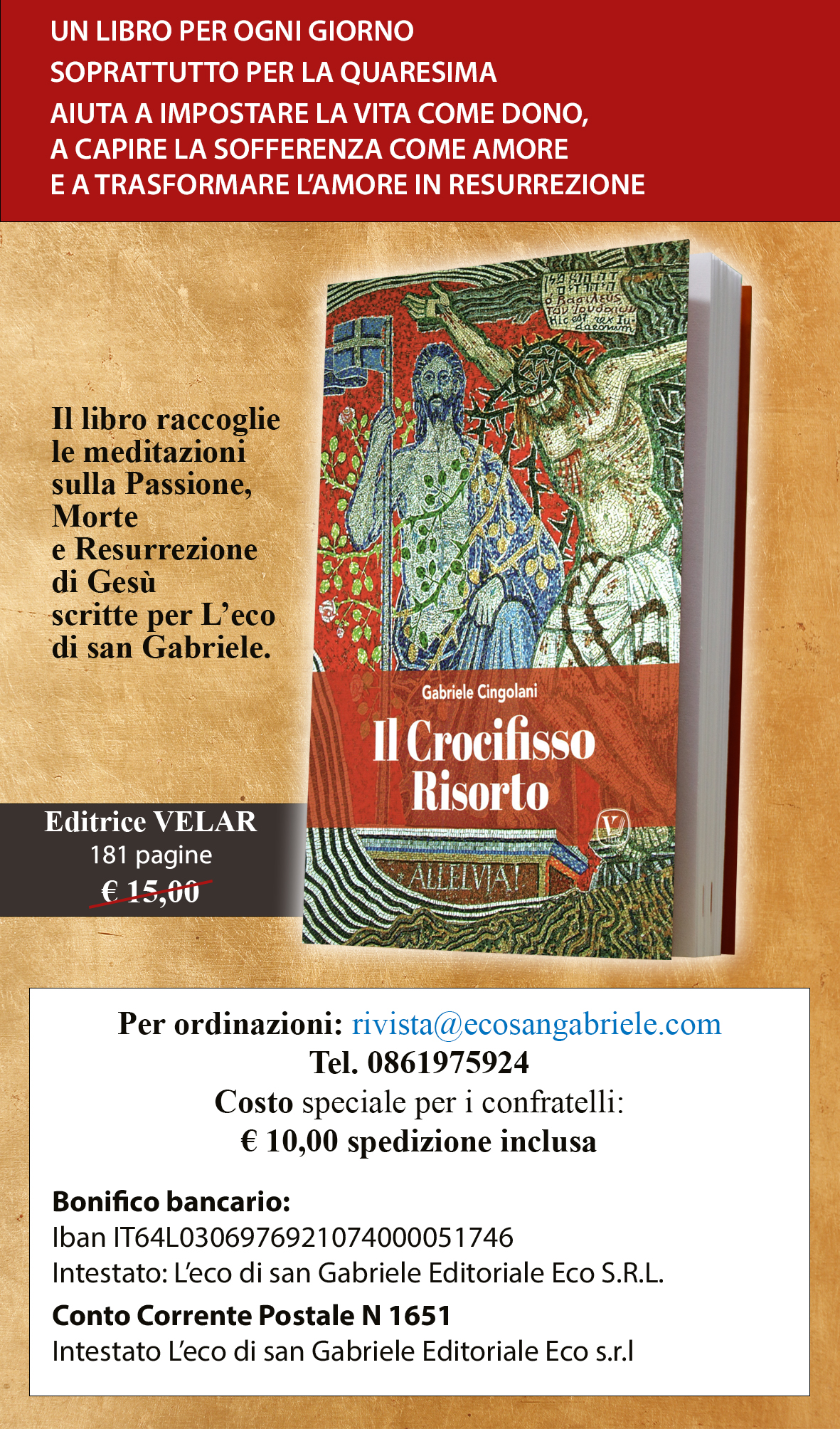Le chiamano stagioni della vita
di Luciano Verdone (Docente di Filosofia – Teramo)
La vecchiaia. Soltanto adesso inizio a rendermi conto di cosa possa essere. Adesso che ci sono quasi dentro. Non sto parlando del corpo lento nei movimenti, della memoria che rifiuta di servirmi. Penso, piuttosto, alla lenta trasformazione degli scenari mentali. Mi riferisco a quella disincantata consapevolezza che s’impadronisce, un po’ alla volta, delle caverne del cuore e mi conduce, piano piano, ad una olimpica noncuranza. Al bisogno di stare solo. Al fastidio per la futilità degli spettacoli e per le realtà non essenziali. Ma questo ora lo apprezzo. So che posso anche sentirmi poco relazionale ed essere, nello stesso tempo, immensamente socievole, aperto alla fiducia nella grandezza umana. Credo, anzi, che una cosa esiga l’altra. Ma cos’è la vecchiaia se non l’approdo trasognato all’isola del tempo senza tempo? Del distacco e della consapevolezza. In qualche modo, il più serio, necessario, tentativo che facciamo di pervenire ad una visione unitaria dell’esistenza. Prima di chiudere la copertina del libro. La giovinezza? Adesso la considero un fiume che ti passa addosso, a tua insaputa. Il giovane è il vero malato. Invasato da una febbre euforica, probabilmente necessaria alla vita. Sempre bisognoso di muoversi, di mettersi alla prova, di fare infinite cose inutili… Quanta impulsività, a quell’età, quanti colpi di testa … Quanta arroganza. Anche quella utile e creativa. Chissà, però, come potevano guardarmi, a quell’età, quando parlavo ed agivo, le persone mature. Le ringrazio, oggi, per la pazienza avuta nei miei confronti. E mi auguro di possederne altrettanta verso i giovani di oggi. Eppure, a pensarci, la vera “superbia vitae”, l’ho sperimentata nell’età di mezzo, quando la rotazione vitale ci attribuisce compiti e responsabilità. E’ in quella fase che siamo più a rischio di eccedere, di rimanere abbagliati dalle nostre possibilità. Ma è proprio vero. Ogni età della vita porta racchiusa, in una mano, la sua pietra preziosa. In ogni caso, fra la protervia del giovane e l’onnipotenza dell’uomo di mezza età, comincio ad apprezzare l’indolenza feconda dell’età senile. Ben venga l’età della contemplazione e della passeggiata lenta. Si, anche quando ci toglie di mano lo scettro del protagonismo sociale. Sempre, però, che ci offra, in compenso, l’umile, profumata, corona della pace con noi stessi, ornata delle bacche salutari dello spirito di lode e di ammirazione. Ne sono convinto. Tutte le stagioni della vita sono necessarie all’equilibrio della mente ed al benessere della società. Sia quella del progetto (giovinezza), sia quella della realizzazione (età adulta), sia quella della consapevolezza (età senile). Guai se i giovani smettessero di sognare e di progettarsi. Ci troveremmo di fronte ad un albero senza chioma. Perché, giovane proviene da “juvare”, giovare, ed indica colui che possiede l’ingenuità di credere che tutto può essere cambiato. E guai se gli adulti si sentissero inerti, irrealizzati. Sarebbe come un albero senza tronco. Infelice, infine, il popolo in cui gli anziani non sono più in grado di trasmettere ai giovani un’identità sociale, una saggezza, una positiva visione del mondo. La società sarebbe, allora, un albero senza radici. Il più grande torto che possiamo fare ai giovani, è quello di ignorarli, costringendoli alla valigia. Mentre, il più grande torto che gli adulti possano fare alla società, in cui vivono, è quello di non assumersi le loro responsabilità. Questo accade quando i genitori diventano complici dei loro figli, anziché educatori. Quando giudici, presidi, insegnanti, poliziotti … si rifiutano di guardare, valutare, intervenire. Come accade nel nostro tempo. Noi abbiamo creato una società piatta, priva di stagioni generazionali, senza bambini, giovani, adulti e senza vecchi. Un mondo in cui i bambini conoscono tutto da piccoli e perdono la fiducia negli adulti. In cui i giovani, sedotti dalla tecnologia, vivono dentro la bolla di un “presente permanente”, senza passato e senza progetti. Un mondo in cui i vecchi non vogliono invecchiare e scimmiottano i giovani. E rifiutano la vecchiaia per paura di essere “rottamati”, in quanto un efficientismo forsennato non attribuisce più, a questa età della vita, né un compito sociale, né uno spazio concettuale. Ecco allora i nostri vecchi diventare degli zombi, delle astrazioni antropiche. Eccoli scomparire dalle strade e dalle piazze, uscire in punta di piedi dalla scena sociale. Ecco che si alzano dalla mensa della vita, non “sazi di giorni”, come i patriarchi di un tempo, ma vuoti ed annoiati. Incamminati verso il nulla.