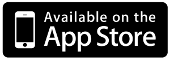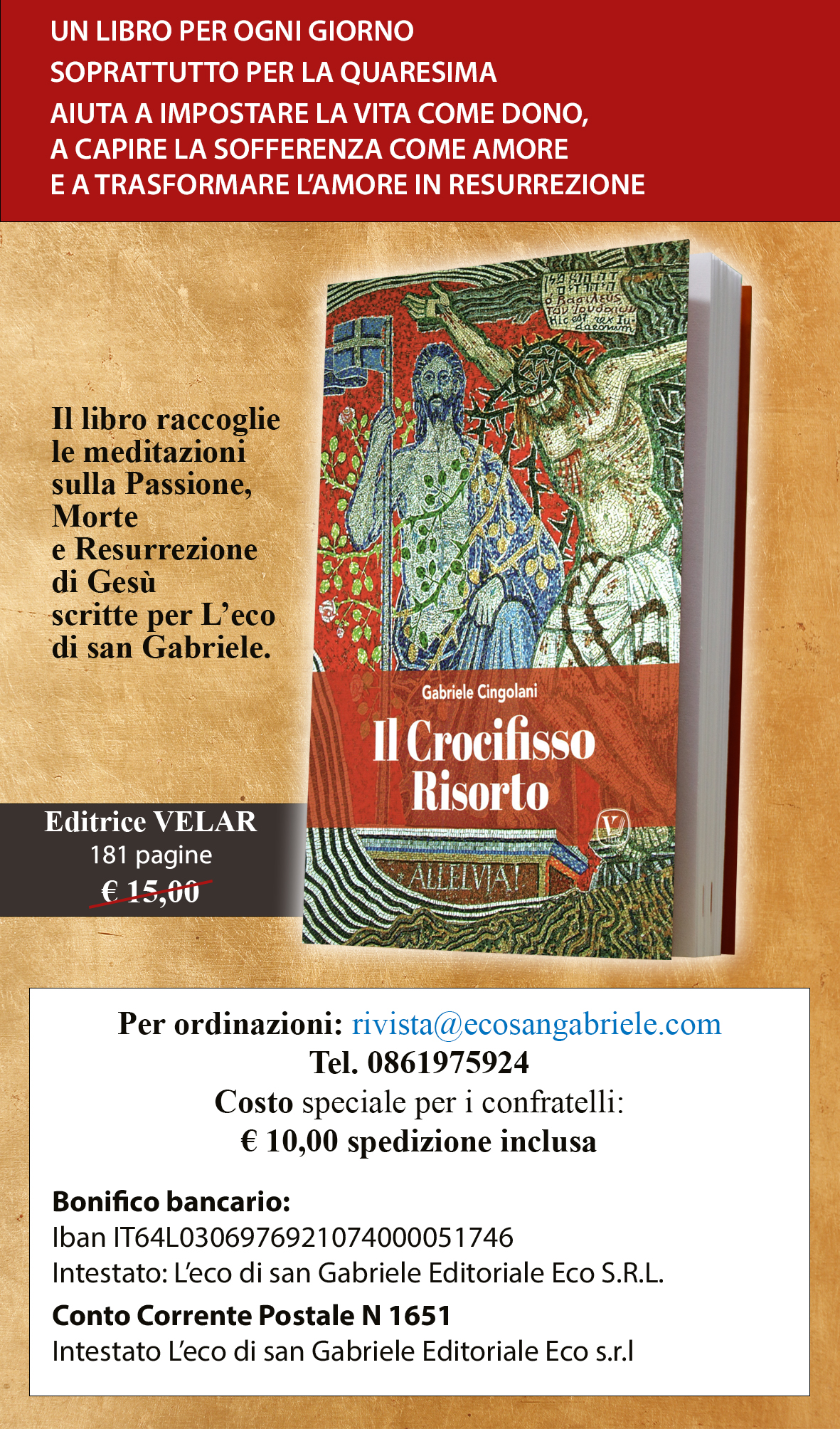DIMMI, CHE FAI, O SILENZIOSO STATO?
Riceviamo e pubblichiamo il “lamento” di una valida archivista autrice di numerose pubblicazioni, vittima di una triste vicenda lavorativa e umana, assai ricorrente, purtroppo, nel mondo dei liberi professionisti.
Quando si lavora in un archivio a contatto con le testimonianze antiche e mentre si è intenti a studiare quelle carte e la loro organizzazione, il confine temporale fra passato e presente sembra dissolversi, ma usciti da quella dimensione spazio-temporale la realtà quotidiana può serbare sorprese, a volte veramente amare. L’archivista – il termine è spesso frainteso con alchimista e, in effetti, ci potrebbero definire degli alchimisti della conservazione – è una figura professionale che solo negli ultimi decenni, e in particolare a seguito del diffondersi delle tecnologie informatiche, ha assunto un più alto rilievo socio-professionale e soprattutto un più largo riconoscimento sociale. Il problema del suo importante ruolo e del futuro destino è assurto all’onore della cronaca e oggi è facile trovare nei media notizie del problema degli archivisti di stato e del rischio che la loro scomparsa potrebbe comportare per il nostro paese, fra cui quello di perdere la propria memoria storica. Ma a dispetto di tutto ciò una categoria di archivisti professionisti, di cui faccio parte, sorella minore se non sorellastra, di quella degli archivisti di ruolo, sebbene con un’alta preparazione, continua a rimanere ignota, se non ignorata dalla maggioranza. In realtà, da anni è forza attiva silente, presente presso istituzioni pubbliche e private e, costretta, il più delle volte, a vivere solo il peso della responsabilità di un gravoso compito, appesantito in molti casi dalle ardue condizioni lavorative e dalla frustrante condizioni contrattuale, senza poter avere il pur minimo riconoscimento. La passione, se da una parte consente di approfondire le conoscenze teorico-pratiche, dall’altra può condurre a ritardare e di fatto impedire di interfacciarsi, in tempo utile, con un mondo economico che cambia volto e interessi.
Nel 1993, uscita da un’università toscana, ispirata da un donchisciottiano ideale di salvare la memoria storica, armata di volontà e dottrina archivistica nonché motivata da quel grande obiettivo ipotizzato allora dalle istituzioni, ossia entrare nell’organico di un ente comunale, ho lavorato per quasi vent’anni al riordinamento di diversi archivi di enti locali, la cui documentazione, ancora negli anni novanta, soffriva di uno stato di abbandono e di quel malessere scaturito dall’intervento di depauperamento e di frammentazione degli archivi delle cancellerie granducali, seguito alla nascita dei nuovi comuni del Regno d’Italia e dai trasferimenti effettuati durante la seconda guerra mondiale. Appena qualche anno dopo iniziò la mia attività, allora anche come collaboratrice della soprintendenza archivistica per la Toscana. Mi piace ricordare la prima volta che entrai in una stanza destinata dall’ente a essere l’archivio di deposito, e di come rimasi affascinata nel ritrovarmi faccia a faccia con quel groviglio di memorie, pur se malamente e indecorosamente assemblate e riunite in scatoloni, che arrivavano fino al soffitto, i più bassi sofferenti e schiacciati dal peso di quelli che stavano sopra. Non mi scomposi e iniziai quel paziente lavoro di scavo e di riorganizzazione di antichi e moderni complessi comunali e privati. Così, fino al 2012, ha continuato a essere il mio lavoro per altri archivi, che se non erano ricoverati in una stanza, erano in cantine, soffitte, in edifici scolastici abbandonati, in garage con infiltrazioni d’acqua e persino in un magazzino per bare. Strutture che potevano presentare problemi statici e umidità. Lavoravo a contatto con quelle carte, in una non solo fisica solitudine, in compagnia di quelli che potevano essere gli ospiti abituali di ambienti insalubri come topi, piccioni vivi e morti, polveri decennali, calcinacci maldestramente fatti cadere sulle carte da un qualche sprovveduto operaio. Le difficoltà logistiche non fermarono il lavoro di riordinamento svolto da tanti altri archivisti nelle mie stesse condizioni. Grazie a questa costanza, molti archivi comunali alla fine del 2000 iniziarono ad acquisire una vera sede, con arredi adeguati e seguiti da personale specializzato, e a poter ricevere al loro interno i primi studiosi e persino a promuovere eventi di valorizzazione.
Intanto per gli archivisti professionisti, all’inizio del 2000, la grande promessa rivelò il suo vero volto. Invece di veder banditi i concorsi per entrare di ruolo divenimmo “archivisti liberi”, liberi di lavorare per enti privati e pubblici con contratti precari come co.co.co, co.co.pro, partita iva e persino ditta individuale (solo di recente il jobs act, accogliendo le direttive europee, ha definito non regolari) e quindi a vivere un esistenza sempre più “liquida”. La situazione, si è poi ulteriormente trasformata in seguito alla crisi economica e alla recente normativa sul lavoro. Pur senza entrare in merito a singoli aspetti positivi e negativi, entrambe hanno obbligato alcuni archivisti “liberi” a vivere altri nuovi destini: i più fortunati “protetti”, già collaboratori delle soprintendenze o degli archivi di stato, hanno potuto continuare le loro funzioni. Altri, nel migliore dei casi, per lo più si tratta di giovani archivisti, hanno trovato collocazione presso ditte di servizi di archiviazione e informatizzazione, ma per i più sfortunati la condizione invece si è aggravata, anzi liquefatta. Lo stato da parte sua ha aggiunto altre difficoltà, inserendo nei bandi pubblici per archivisti, non si può dire quanto inconsapevolmente, un limite di età (nonostante sia stato condannato dall’Unione Europea), che impedisce a noi cinquantenni di partecipare ai concorsi pubblici attesi e agognati per anni.
Sopravvissuta alle difficoltà di una società, che tutti riconoscono non premiare per i meriti ma per le “conoscenze”, esclusa dalle mie precedenti collaborazioni perché non più giovane e competitiva per il mercato del lavoro (“lei ha troppa esperienza” – mi sono sentita dire – “noi cerchiamo giovani”), rischio oggi di soccombere, in quanto non solo da tre anni non riesco a trovare più una collocazione lavorativa, ma perché a causa di ciò la mia stessa esistenza sta assumendo connotazioni drammatiche.
La mia dignità, però, mi impone di prendere atto e accettare questa pur triste condizione, visto che cambiarla risulta ardua se non impossibile, e di lanciare questo disperato lamento e una domanda: Che fai tu, stato? Dimmi, che fai, o silenzioso stato? Antonietta Quarta