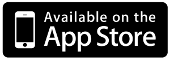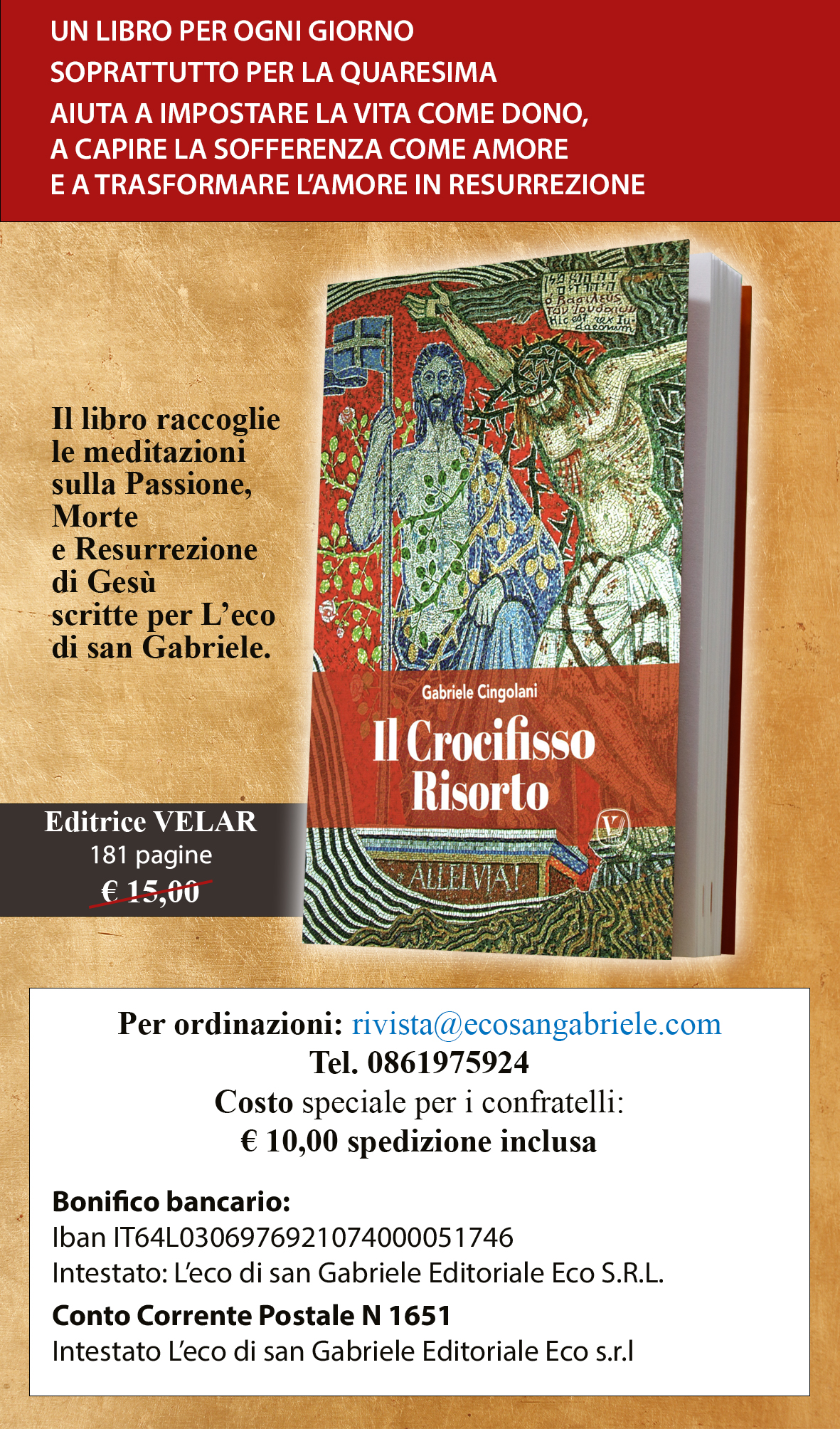LIBERI TUTTI?
SOVRAFFOLLAMENTO, AUMENTO DEI SUICIDI, MANCANZA DI SPERANZA: NE PARLIAMO CON LUIGI MANCONI, AUTORE INSIEME A STEFANO ANASTASIA, VALENTINA CALDERONE E FEDERICA RESTA DEL LIBRO-DOSSIER ABOLIRE IL CARCERE. ANCHE PAPA FRANCESCO È TORNATO RECENTEMENTE A DENUNCIARE LA DRAMMATICA SITUAZIONE NELLE CARCERI ITALIANE
“Purtroppo nelle carceri sono tante le persone che si tolgono la vita, a volte anche giovani. Oggi desidero esprimere la mia vicinanza in modo speciale alle madri che hanno figli sofferenti, figli malati, figli emarginati, figli carcerati. Una preghiera particolare per le mamme dei figli detenuti, perché non venga meno la speranza”. Papa Francesco, dopo il richiamo fatto in occasione della visita di fine agosto a L’Aquila, recentemente è tornato di nuovo a denunciare la gravità della situazione nelle carceri italiane nel corso di un’udienza generale. Parliamo di un dramma che si trascina da tempo e che oggi ha assunto contorni veramente vergognosi. Gli ultimi dati forniti da Antigone, l’Associazione per i diritti e le garanzie nel sistema penale, (ovviamente ci riferiamo a quelli raccolti al momento di mandare in stampa questo numero) presentano un quadro raccapricciante. Dall’inizio del 2022 siamo già a 59 suicidi, 15 solo nello scorso agosto, circa una persona ogni quattro giorni. In tutto il 2021 erano stati 57. In pratica ci si uccide 16 volte di più rispetto a quanto non avvenga nel cosiddetto mondo libero. A livello generale il nostro Paese conta un basso tasso di suicidi, riferito alla popolazione carceraria, però, il dato aumenta sensibilmente collocandoci al decimo posto tra i 47 Paesi del Consiglio d’Europa. Naturalmente, è bene ricordarlo, dietro ogni morte c’è una storia che spesso fa riferimento a dipendenze, disagi psichici, isolamento, assenza di speranza, incompatibilità con il regime carcerario, eccetera.
Da anni si parla di riforma del sistema carcerario, di sovraffollamento, di situazione esplosiva. Continui e stucchevoli bla bla che di fatto non hanno mai partorito una soluzione concreta. L’emergenza resta, anzi, aumenta e il sistema fa sempre più acqua. C’è bisogno più che mai, dunque, di una visione strategica dei tanti problemi che affliggono il sistema penitenziario. Al di là delle buone intenzioni, guarda caso spesso coincidenti con le scadenze elettorali…, è arrivato il momento di dare risposte serie e adeguate. L’Associazione Antigone, intanto, ha lanciato la campagna Una telefonata allunga la vita, chiedendo una riforma urgente del regolamento del 2000 che porti a una liberalizzazione delle telefonate per i detenuti. “In un momento di sconforto – afferma il presidente Patrizio Gonnella – sentire una voce familiare, può aiutare la persona a desistere dall’intento suicidario. I 10 minuti a settimana previsti attualmente non hanno più nessun fondamento, né di carattere tecnologico, né economico, né securitario. Cambiare quel regolamento non comporta alcun atto legislativo”. Un piccolo intervento sicuramente dagli effetti positivi, in attesa ovviamente di mettere mano a una riforma radicale che renda la pena meno afflittiva e nel rispetto della dignità umana. Proprio come recita l’articolo 27 della Costituzione: “Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato”.
In questa direzione, Luigi Manconi, Stefano Anastasia, Valentina Calderone e Federica Resta hanno da poco mandato in libreria un volume dal titolo Abolire il carcere (Chiarelettere editore, pp.169, euro 16,00) con la prefazione dell’ex magistrato, giurista, saggista e scrittore italiano, Gherardo Colombo e la postfazione di Gustavo Zagrebelsky, giurista e accademico italiano, giudice costituzionale dal 1995 al 2004 e presidente della Corte Costituzionale nel 2004. “Gli autori del libro – osserva Gherardo Colombo – tengono i piedi ben fermi per terra, non pensano all’azzardo di abolire del tutto il carattere retributivo della pena (anche se ci vanno vicino) e si rendono conto (su questo li seguo anch’io) che le modifiche che propongono, così significative, non possono essere introdotte dall’oggi al domani. Credo possa continuare a spaventare l’idea dell’abolizione dell’ergastolo, che gli autori pure sostengono (e che mi vede completamente d’accordo): ritengo tuttavia che condividerebbero, ove si arrivasse a escludere la pena perpetua, l’introduzione di misure che impediscano, a chi continui a essere pericoloso, una volta scontata la pena, di riprendere a fare del male a chi gli sta intorno”.
“Da qualche tempo – gli fa eco Gustavo Zagrebelsky – si discute di giustizia riparativa, restaurativa, riconciliativa. Studi sono in corso, promossi anche da raccomandazioni internazionali; sperimentazioni nel campo del diritto penale minorile e per i procedimenti su querela di parte. Si tratta di una prospettiva nuova e antichissima al tempo stesso che potrebbe modificare profondamente le coordinate con le quali concepiamo il crimine e il criminale: da fatto solitario a fatto sociale; da individuo rigettato dalla società a individuo che ne fa comunque sempre parte, pur rappresentandone un aspetto patologico”.
Ma qual è l’obiettivo di questo libro? Veramente è possibile ipotizzare una società senza carcere? “Il nostro lavoro – spiega Luigi Manconi, noto politico, sociologo, scrittore e critico musicale – ambisce a dimostrare l’opportunità di una simile domanda e la fondatezza della nostra risposta positiva. Sì, abolire il carcere è possibile, innanzitutto nell’interesse della collettività, di quella maggioranza di persone che pensano di non essere destinate mai a finirci e che con lo stesso mai avranno alcun rapporto nel corso della intera esistenza. L’abolizione del carcere è, insomma, una ragionevole proposta per la sicurezza dei cittadini, che ne avrebbero tutto da guadagnare.
In che modo ci guadagnerebbero se chi sbaglia resta impunito?
Perché a dispetto delle sue promesse il carcere non dissuade nessuno dal compiere delitti, rieduca molto raramente e assai più spesso riproduce all’infinito crimini e criminali, e rovina vite in bilico tra marginalità sociale e illegalità, perdendole per sempre. E perché mette frequentemente a rischio la vita dei condannati, violando il primo degli obblighi morali di una comunità civile, che è quello di riconoscere la natura sacra della vita umana anche in chi abbia commesso dei reati, anche in chi a quella vita umana abbia recato intollerabili offese. E sia per questo sottoposto alla custodia e alla funzione punitiva degli apparati statali.
Già quarant’anni fa nel Paese si parlava di una via alternativa alla necessità del carcere. Vista la situazione attuale, però, siamo fermi ancora alle intenzioni…
È vero, sono stati anni in cui le migliori intenzioni si sono scontrate con la ruvida materialità di un sistema penitenziario che è sembrato irriformabile. E che, per contro, ha riprodotto ottusamente sé stesso, anche oltre sé stesso, in altri luoghi di detenzione, non meno afflittiva, non meno degradante, non meno inumana: dagli Ospedali psichiatrici giudiziari (Opg) ai Centri di permanenza per i rimpatri (Cpr) destinati agli stranieri senza titolo di soggiorno. Proviamo allora a invertire l’ordine del discorso. Il carcere come luogo di pena non è sempre esistito. Anzi, nella lunga storia dell’umanità è un’invenzione abbastanza recente. E ciò nonostante costellata di denunce e contestazioni, dalla grande letteratura agli scritti dei costituenti riuniti in un fascicolo de Il Ponte da Piero Calamandrei nel 1949. Insomma, non siamo i primi né gli unici a pensare che il carcere possa essere abolito. L’idea di fare a meno della galera come luogo di esecuzione delle pene, in realtà, ha ormai una lunga storia, fatta di teorie filosofiche, suggestioni letterarie, manifesti politici e sperimentazioni pratiche, che riprendiamo in questo libro.
Qual è oggi la situazione carceraria?
Ben 3310 persone sono morte nelle carceri italiane negli ultimi ventidue anni: più di 150 ogni anno, di cui almeno un terzo per propria scelta, ricorrendo ai vari strumenti che consentono a chi si trovi recluso di togliersi la vita: dall’impiccagione alle sbarre della cella all’aspirazione del gas del fornello. Più della metà dei detenuti sopporta la reclusione solo grazie all’uso abituale di psicofarmaci, mentre la gran parte, quasi il 70 per cento, è destinata a rientrare in carcere entro un breve periodo di tempo. Per questo nel libro parliamo più diffusamente della sua intollerabilità e degli effetti altamente letali che ha su chi vi è recluso e su chi vi lavora come una delle ragioni che inducono a considerare l’opportunità della sua abolizione.
In che modo sarebbe possibile?
Il nostro e altri ordinamenti penali conoscono una grande varietà di pene non detentive, come quelle che limitano la libertà di movimento senza ricorrere a una cella, quelle che impediscono ai condannati di compiere determinati atti o che costringono a realizzare qualcosa a favore della collettività. Nel libro passiamo in rassegna le alternative già oggi sperimentate in molte parti del mondo, e perfino in Italia. E, infine, individuiamo dieci cose da fare subito per indirizzare energie e risorse verso l’abolizione della pena detentiva. Certo, il nostro ambizioso obiettivo va avvicinato e raggiunto attraverso un tragitto inevitabilmente lungo e faticoso. Ma anche i piccoli passi e i modesti risultati possono essere alla nostra portata e rivelarsi efficaci solo se collocati all’interno di una prospettiva che è necessariamente quella: l’abolizione del carcere. La riforma più elementare e l’intervento più prudente sono destinati ad avere successo solo se pensati e perseguiti come altrettanti passaggi verso quella meta finale che è appunto rendere superflua la prigione.
Quindi, secondo le vostre analisi la prigione non costituisce un efficace strumento di punizione…
Assolutamente no. Quanti vi si trovano reclusi sono destinati in una percentuale elevatissima, più del 68 per cento, a commettere nuovi delitti. Non produce, dunque, l’effetto di ridurre il tasso generale di criminalità, ma consegue il risultato opposto: innalzarlo ulteriormente, affinando le capacità delinquenziali dei detenuti, insediandoli più profondamente nel tessuto della illegalità e negando loro ogni alternativa di vita. Riducendo il potere di deterrenza della pena si limita la capacità di rassicurare i cittadini rispetto alle minacce e ai pericoli che quegli stessi privati della libertà possono rappresentare. Non solo: il carcere si conferma come un luogo di aggregazione e di integrazione tra diverse figure criminali, una sede ideale per rafforzare alleanze tra singoli e gruppi illegali. Allo stato attuale, le diverse finalità della carcerazione, inoltre, tendono a ridursi via via a una sola e a concentrarsi, alla prova dei fatti, nell’esclusiva funzione di affliggere il condannato per il reato commesso. Tale afflizione diventa, in questo modo, la sostanza stessa della esecuzione della pena; e la degradazione del corpo e della personalità del condannato appare come la conferma della “retribuzione” impostagli. In altre parole, attraverso questo processo, la pena si mostra nella sua essenzialità come vera e propria vendetta.
Vendetta?
Sì, è in quanto tale, essa risulta priva di qualunque effetto razionale e del tutto estranea a quel fine che la Costituzione indica nella “rieducazione del condannato”. Se la pena, infatti, fosse considerata esclusivamente per la sua finalità “retributiva” – ovvero compensare la colpevolezza del reo – saremmo in presenza di una misura che ha il solo obiettivo di arrecare dolore, ovvero affliggere il detenuto. E ciò la renderebbe iniqua e sostanzialmente immorale. A fronte di ciò, il cuore di una possibile moralità risiede proprio in quello che consideriamo come il più rigoroso e radicale habeas corpus, ovvero l’incondizionata tutela dell’integrità e della incolumità del corpo e della personalità del condannato. In caso contrario non c’è dubbio che è la violenza istituzionale, fino all’esecuzione capitale, la forma di sanzione più equa. Nel caso estremo, solo la pena di morte rappresenta effettivamente la retribuzione più “proporzionata”: morte per morte. Non c’è il minimo dubbio, infatti, che la pena capitale – sotto il profilo della massima utilità – risulti più incisiva di lunghe e costose carcerazioni, meno capaci di bloccare la diffusione del delitto e la sua perpetuazione.
La pena capitale considerata una retribuzione “più proporzionata” credo vada al di là del paradosso più estremo…
A conferma della maggiore “ragionevolezza” che avrebbe, in un simile contesto, la pena di morte, si può far riferimento a quanto accaduto nei primi giorni del 2015, quando un ergastolano belga chiese di poter accedere al protocollo per l’eutanasia, ricevendo all’inizio una risposta positiva da parte del giudice competente. Frank Van den Bleeken avrebbe voluto esser curato per la sua patologia – si definisce uno “stupratore seriale” – in una clinica specializzata, ma non gli era stato concesso, nonostante ripetute richieste. Lo Stato, di fatto, avrebbe preferito la sua morte, con l’ipocrisia di un atto giustificato come rispondente alla sua volontà e dunque alla sua dignità. Una dignità che non era bastata a far sì che si affrontassero i misteri della sua personalità, che gli si concedesse la chance di una uscita dalla dimensione dell’orrore, che lo si liberasse dalla continua sollecitazione al suicidio, a quanto si legge, da parte di altri detenuti. Così la pena senza speranza dell’ergastolo sarebbe ridiventata, anche in senso materiale, pena di morte. Un facile disimpegno rispetto alla sua condizione. Un costo economico in meno. Un interrogativo eluso sul problema del male. Considerare “ragionevole” la pena capitale a fronte di altre pene disumane non è dunque mero esercizio del paradosso intellettuale né tenebrosa manifestazione di spietatezza. È, piuttosto, la conseguenza ultima del vicolo cieco in cui è precipitata la decadenza teorica e pratica del concetto di pena.
A suo avviso quali sono i punti di maggiore criticità del modello carcerario?
Penso in particolare alla sua rozzezza. La prigione è uno strumento palesemente non sensibile e non intelligente: esso può essere applicato solo indistintamente e grossolanamente, senza alcuna duttilità e flessibilità e senza la minima capacità di adattamento alla complessità e varietà del reale. In estrema sintesi e in buona sostanza, il carcere è lo stesso per chi vi finisce perché ha rubato un pacco di biscotti e per Bernardo Provenzano…
Ci fa un esempio?
Se un diciottenne colombiano viene arrestato con l’accusa di rapina aggravata per aver sottratto un tester di profumo, dopo aver rimosso il codice di controllo, deve trascorrere un determinato periodo di tempo (in custodia cautelare o in esecuzione della pena) all’interno di un luogo chiuso, dove viene privato della libertà personale e la sua integrità psichica e fisica è messa in pericolo: in cosa differisce la sua pena da quella a cui viene sottoposto un criminale altamente pericoloso come è stato Provenzano? Oltre alla scarsa rilevanza sociale del furto di un tester per cui la detenzione appare misura eccessiva, si dovrebbe considerare con altrettanta attenzione la stessa congruità della permanenza in carcere per chi, come Provenzano, ha mostrato fino alla morte il seguente quadro clinico, redatto dai medici dell’ospedale San Paolo di Milano: l’uomo “presenta un grave stato di decadimento cognitivo, trascorre le giornate allettato alternando periodi di sonno a vigilanza. Raramente pronuncia parole di senso compiuto o compie atti elementari se stimolato. L’eloquio, quando presente, è assolutamente incomprensibile. Si ritiene incompatibile col regime carcerario”. E in effetti è proprio così. La qualità della pena comminata per la gran parte delle fattispecie penali del nostro ordinamento è essenzialmente quella: la reclusione. Ovvero la misura che, nel nostro codice, è prevista solo per i delitti e che può avere una durata compresa tra quindici giorni e l’ergastolo. Se poi si tiene conto che per le contravvenzioni la pena detentiva è denominata arresto ma può comportare le stesse conseguenze di restrizione della libertà, è facile dedurre che la prigione costituisce il cuore stesso dell’idea e della pratica della punizione per come il codice e la prassi giudiziaria l’hanno definita.
Però ci sono tanti detenuti che attraverso corsi di formazione o attraverso il lavoro svolto all’interno del carcere, una volta fuori in galera non ci sono più rientrati…
Vero, ma il bilancio resta clamorosamente negativo e insistere sulle ammirevoli “buone prassi” rischia di farle apparire come foglie di fico sulla vergogna di un carcere insensato. Prenderne atto e pensare a come farne a meno è il minimo richiesto a quanti prendano sul serio il problema della devianza e della criminalità, delle loro cause e dei loro effetti. Possiamo continuare a invocare, minacciare, eseguire pene detentive sempre più dure per qualsiasi violazione della legge se il loro risultato, quando vengono applicate, è quello descritto da una fonte ufficiale come lo stesso Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria? Realismo e misura impongono di trovare alternative, alla pena detentiva oggi così come all’istituzione carceraria domani. D’altro canto, la Costituzione non parla mai di carcere, né di pena detentiva. Anche se i costituenti conoscevano solo il carcere (per averlo personalmente scontato durante il regime fascista) e la pena capitale, in modo saggio e miracolosamente lungimirante non aggettivarono le pene, lasciando campo libero a un legislatore che voglia cambiare radicalmente la fisionomia delle sanzioni penali. Siamo dunque autorizzati a osare.