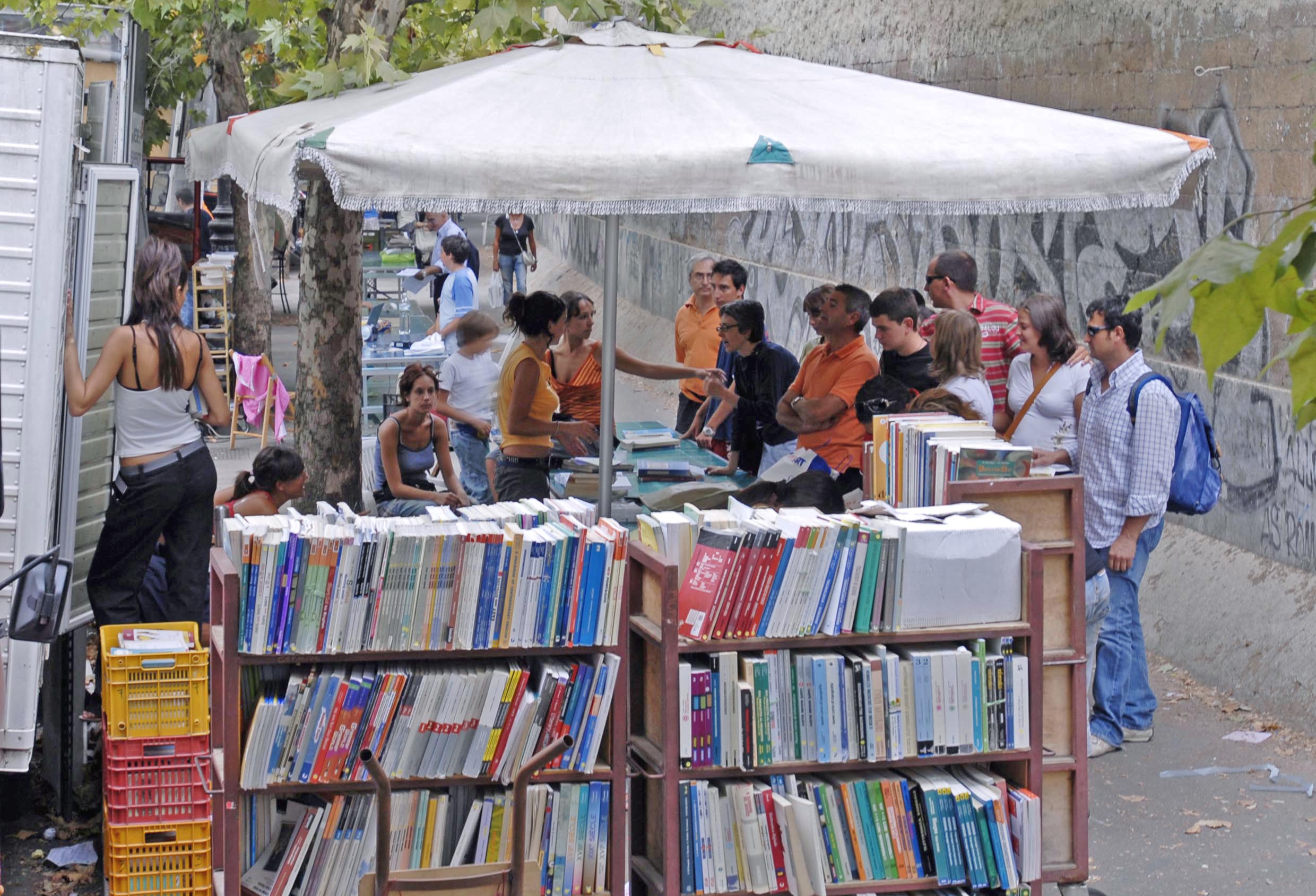A fronte di una spesa annua che si aggira sui 500 euro l’anno per ogni famiglia e che supera i 680 euro per chi frequenta il primo anno di liceo, quando oltre ai libri di testo vanno acquistati anche i dizionari, appena 14 studenti su 100 ne hanno avuto accesso…
La spesa media per acquistare i libri scolastici, per le famiglie italiane, si aggira attorno ai 500 euro l’anno, arrivando a sfiorare i 700 euro se si affrontano gli anni delle scuole superiori (sul liceo, pesa anche l’acquisto di più dizionari). Eppure, nell’anno scolastico in corso, solo 14 studenti su 100 hanno avuto accesso al Bonus libri scolastici, accedendo a un fondo complessivo di 133 milioni. Il problema fondamentale è che i requisiti non sono uguali per tutti e cambiano da Regione a Regione, oltre ai tetti Isee diversi. È quanto emerge dalla ricerca di Cittadinanzattiva con il Quotidiano del Sud sul Bonus libri scolastici.
Nel nostro Paese, le uniche Regioni dove i testi sono gratuiti sono Trentino Alto Adige e Valle d’Aosta. Per il resto, sono le Regioni che singolarmente definiscono i requisiti (fasce Isee) per beneficiare del Bonus, come anche le modalità e la scadenza per la presentazione delle domande. Sono poi i Comuni che erogano i contributi, ad eccezione della regione Lombardia, unica regione nella quale le domande vanno presentate direttamente alla Regione così come l’erogazione del contributo viene effettuata dallo stesso ente, senza passare per i Comuni.
“Su una platea di 4.152.491, – spiega Cittadinanzattiva -, a riceverlo sono appena 589.196 studenti appartenenti a famiglie con un reddito inferiore a 15.493,71 euro, Il tetto Isee per accedere al contributo viene stabilito dalle Regioni e dai Comuni che in alcuni casi possono aggiungere ulteriori fondi. Le famiglie meno abbienti, ossia con un reddito inferiore ai 15.493.71 euro l’anno, rappresentano il 13,4% a livello nazionale, con punte del 25,6% in Campania, 24,1 in Abruzzo, oltre il 20% in Calabria e Sicilia (ultimi dati Istat, 2020-2021)”.
La Basilicata e la Sardegna, spiega l’analisi di Cittadinanzattiva, fissano la soglia più alta di Isee in 20mila euro, allargando dunque la platea dei beneficiari. Abruzzo, Lazio e Umbria la fissano in massimo 15.493,71 euro. Poco più in Toscana, Lombardia, Piemonte, Emilia Romagna, Molise e Veneto (queste ultime tre però prevedono un contributo maggiore per chi ha un Isee inferiore ai 10.632,94 euro).
Segue il Friuli Venezia Giulia dove possono accedere al contributo le famiglie con Isee fino a 14.000 euro, stesso tetto per la Puglia per le famiglie con 3 o più figli la Campania in 13.300 euro ma con un maggiore contributo per chi ha meno di 10,633 euro.
In Sicilia accedono al Bonus le famiglie con Isee fino a 10.632,94 euro. In Calabria il tetto massimo per accedervi, che era di 6 mila euro, è stato innalzato a 15.748,78 euro grazie a un provvedimento destinato a 36mila studenti calabresi per 16 milioni di euro deliberati dalla giunta regionale. In Liguria è previsto un rimborso, con percentuali tra il 50 e il 60% della spesa sostenuta, a copertura di tutte le fasce di Isee fino a 50 mila euro; dal secondo figlio in poi, la soglia si abbassa per permettere una percentuale di rimborso più elevato e comunque una priorità in graduatoria se l’Isee non supera i 15mila euro.
“L’indagine evidenzia come il ricorso al Bonus libri sia importante e necessario per le famiglie anche se insufficiente considerato il costo complessivo che queste devono affrontare annualmente per l’acquisto di libri e materiali didattici, il cui importo è almeno 3-4 volte superiore a quello del bonus. Attualmente, molte vengono escluse economicamente dalla fascia Isee considerata, con un valore che varia da regione a regione”, dichiara Adriana Bizzarri, coordinatrice nazionale Scuola di Cittadinanzattiva che avanza alcune proposte: “Lo Stato dovrebbe porsi l’obiettivo di garantire, progressivamente, la gratuità dei libri di testo per la scuola dell’obbligo. Ciò rappresenterebbe una scelta di fondamentale importanza per il superamento delle disuguaglianze sociali ed economiche di migliaia di minori, per garantire loro l’effettiva esigibilità del diritto allo studio, come deterrente alla dispersione e come incentivo allo studio”.