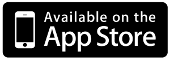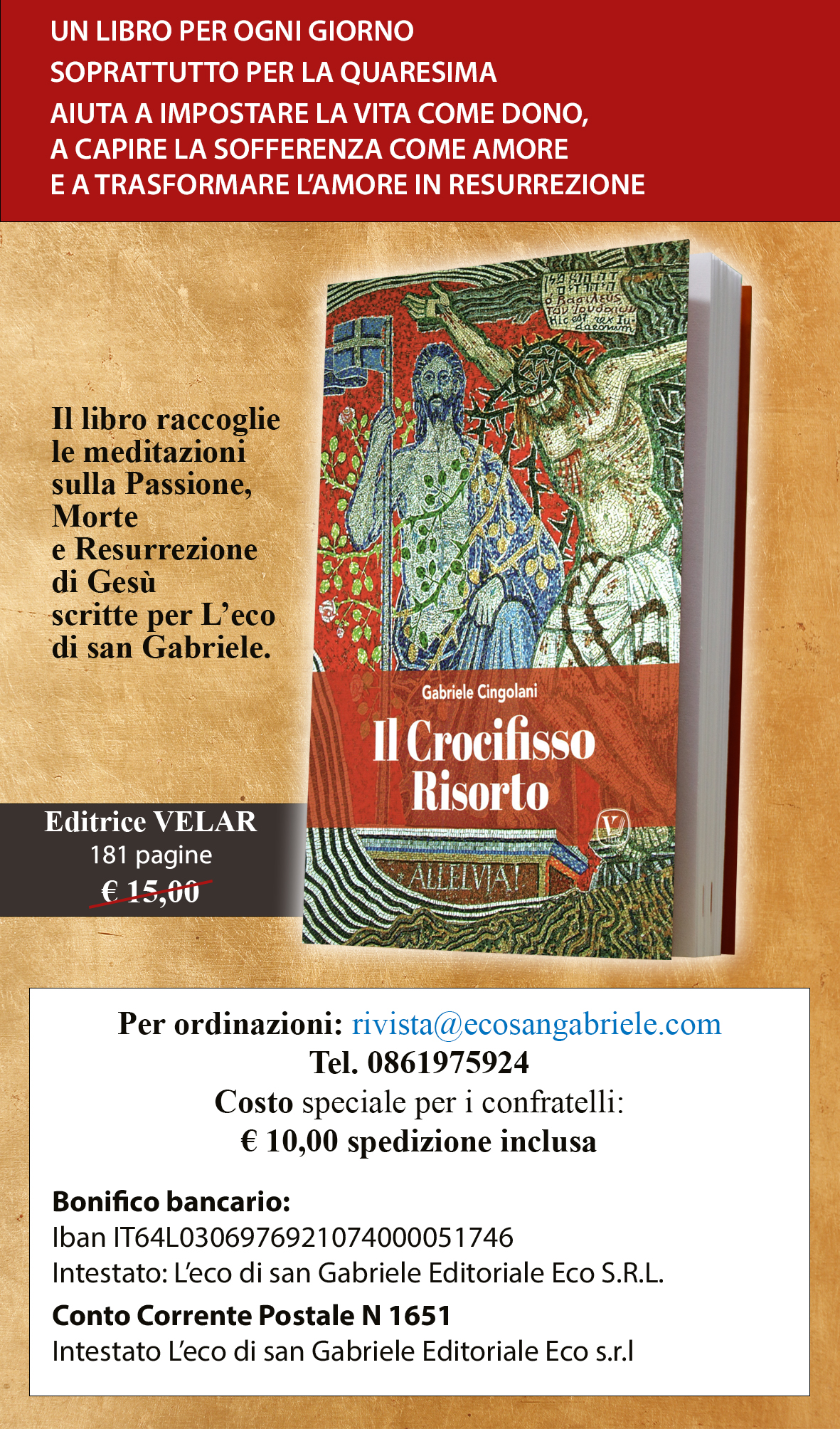NON RIESCO AD ABITUARMI ALLA MORTE…
Salve, sono una giovane infermiera in servizio in ospedale da soli tre anni. Pochi per parlare di esperienza, tanti, però per accettare la morte. Lo so, fa parte della vita e ognuno di noi quando nasce sa già cosa l’aspetta, però quando essa arriva causa sempre dolore e disperazione. Ecco, allora, che le scrivo per avere un consiglio. Come comportarsi dinanzi alla scomparsa della speranza? Cosa dire ai tanti malati sopraffatti dagli spasmi del dolore? Quali parole per i famigliari che giorno dopo giorno assistono pietosamente allo spegnersi di un loro caro? Mi piacerebbe inoltre conoscere il suo pensiero in merito all’accanimento terapeutico? Grazie molte. Vesna
Forse non siamo abituati alla morte. Non più. Anche perché i morti, tanto spesso, non si vedono. Si vedono le casse da morto, l’agenzia funebre, ma il morto troppo spesso muore in un ospedale, o casa di cura, da solo, con diligenti operatori ma sradicato già dalla vita relazionale. Questo si afferma della nostra società occidentale dove gli uomini vivono come se non dovessero morire mai e muoiono come se non avessero mai vissuto, secondo un pensiero del Dalai Lama. D’altra parte le scoperte scientifiche sembrano indicare che tutto si possa risolvere, la pubblicità che si può rimanere sempre giovani o comunque sempre in forma e i media fanno della morte uno spettacolo. Però ci sono dei luoghi marginalizzati a livello psicologico e spesso anche a livello territoriale dove tutto si accumula e, direi, presenta il conto. Mi riferisco ovviamente alle case di cura, agli ospedali. È il conto che tu presenti.
Non credo che ci siano tante parole da poter dire. Spesso il silenzio e la presenza sono la forma migliore di rispetto per il malato e per il mistero della morte. La speranza invece è sostenuta dall’affetto. Quando un malato semplicemente è amato e si ha verso di lui comprensione e tenerezza, il tutto sostenuto da una relazione empatica e da una presenza assidua, allora l’infermo forse si rende conto che è ancora importante per qualcuno. È l’amore che fa vivere, come la solitudine e l’indifferenza uccidono. Secondo me, questo è l’elemento base per una relazione di consolazione, per una parola che dica oltre l’ovvietà della situazione o anche per un silenzio che sia pienezza di compassione e non il vuoto del nonsenso.
Da qui si può partire in tre direzioni. Una verso chi assiste, l’altra verso il malato e la terza verso coloro che gli vogliono bene. Chi assiste se si rende conto, come dice papa Francesco, che il malato è “la carne sofferente di Cristo”, può comprendere che sta facendo la cosa più importante della vita dove il momento presente si scrive nell’eternità (cfr Mt 25, 31ss). Senza questa profonda convinzione i santi della carità e della compassione, come madre Teresa, non esisterebbero.
Per il malato, nella fede, si può aprire uno spiraglio che faccia vedere un po’ di luce nel tunnel grigio della malattia e della morte che si avvicina. È il Dio della vita che ci riprende.
La terza direzione verso coloro che hanno voluto bene al defunto è che la relazione vissuta rimane e si proietta verso un coronamento ed una pienezza sperata.
Queste realtà però non si predicano, come se avessimo delle risposte pronte per ogni problema, si comunicano con l’atteggiamento. Anche perché abbiamo una sola grande speranza che ci è stata donata dal nostro Signore crocifisso e risorto. Però come la fede così la speranza si trasmette per attrazione. Come un abbraccio comunica amore più di qualunque discorso. E in certi momenti abbiamo bisogno più di un abbraccio che di chiacchiere. E nell’abbraccio passano tante spiegazioni inespresse ma profondamente vere.
Sull’accanimento terapeutico ti direi di rivolgerti al moralista. Ti potrebbe dare una risposta più articolata e completa. Però, in sintesi, si può dire che la dignità del morire umano si tiene lontana da due estremi: l’accanimento terapeutico e l’eutanasia.